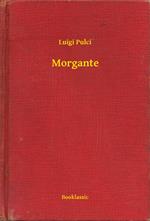(Firenze 1432 - Padova 1484) poeta italiano. Di nobile famiglia decaduta, intorno al 1460 fu introdotto in casa Medici da B. Scala e F. Castellani. Dopo il 1470, coinvolto nelle disavventure economiche dei fratelli Luca e Bernardo, lasciò Firenze, facendosi affidare dal Magnifico incarichi di fiducia a Camerino e a Napoli. Nel 1472 entrò al servizio di Roberto Sanseverino, un condottiero al soldo della signoria, e per suo conto, nel 1473, compì missioni a Bologna, Milano e Venezia. Negli ultimi anni tornò saltuariamente nella sua città, ma morì a Padova, e fu sepolto in terra sconsacrata come eretico.Temperamento bizzarro, di cultura limitata ma non superficiale, si era imposto per qualche anno alla brigata medicea tesa al recupero delle molteplici espressioni della tradizione «popolare», finché poi, cambiati progressivamente in senso umanistico e filosofico gli amici e gli interessi, il Magnifico non aveva allentato e raffreddato i rapporti con chi, come P., era rimasto del tutto alieno da quelle tematiche e da quei lessici o addirittura si provava in teorie e interessi (materialismo, magia) del tutto incompatibili con la filosofia «ufficiale» della nuova Firenze, il platonismo ficiniano.Anche nelle opere minori (il ricco Epistolario; i numerosi sonetti, fra cui spiccano, per violenza polemica, quelli contro il letterato Matteo Franco e quelli contro M. Ficino; la favola villereccia Beca da Dicomano, composta a imitazione parodistica della Nencia da Barberino di Lorenzo de’ Medici; le 160 stanze di ascendenza canterina della Giostra di Lorenzo e la continuazione del Ciriffo Calvaneo, il poema in ottave iniziato dal fratello Luca) P. rivela un’immaginazione vivace, spontaneamente portata alle interpretazioni comiche e grottesche, e un gusto spiccato per la parola colorita, corposa e plebea, talora addirittura gergale (suo è un Vocabolarietto di lingua furbesca, elenco di voci gergali a uso della cerchia laurenziana).Tali caratteri trovano piena espressione nel poema cavalleresco in ottave Il Morgante, commissionatogli da Lucrezia Tornabuoni e pressoché ultimato prima del 1470, ma pubblicato nel 1478 in 23 canti («cantari») e nel 1483 (col titolo di Morgante maggiore) in 28 canti. Quest’opera, la cui materia, in passato, è stata sempre messa in un rapporto (ora invece discusso) di stretta dipendenza da due poemi anonimi e anepigrafi noti come Orlando e Spagna, è sostanzialmente una parodia di quelle canzoni di gesta che, ben presenti agli immediati destinatari del poema (in primis la brigata medicea, alla quale P. «leggeva» l’opera man mano che era composta), costituiscono la base sulla quale si esercita una parodia linguistica di evidente ascendenza burchiellesca, tendente a privilegiare tecnicismi e voci dialettali fortemente espressive. A questo impegno (a riprova che nel Morgante non si dà altra tensione unitaria che quella linguistica) fa riscontro, sul piano dello svolgimento della vicenda, una successione meccanica e schematica di personaggi, situazioni ed episodi, cui corrisponde il funzionamento narrativo altrettanto meccanico dell’ottava. Anche la tematica soggiace a questa sistematica riduzione: essa infatti è risolta, soprattutto nei primi 23 cantari, in chiave popolaresca o addirittura picaresca: Carlo Magno è presentato come un vecchio svanito, i paladini si comportano da briganti più che da eroi, le dame sembrano prefigurare la Dulcinea di Cervantes. Se fra i personaggi della tradizione cavalleresca quello che meglio si addice al gusto pulciano è Rinaldo, pronto alle avventure amorose come alle risse, ben più compiutamente l’autore si esprime nella coppia Morgante-Margutte: il gigante istintivo e bonario (che muore al canto XX, dopo atti di prodigioso eroismo, per la puntura di un granchiolino) e il mezzo gigante vorace, il furfante che enuncia un credo materialista e irriverente rimasto famoso (canto XVIII) e muore soffocato dalle sue stesse risate. A un clima culturale più «impegnato» vanno invece ricondotti i cinque cantari aggiunti nell’83, ispirati all’anonima Rotta di Roncisvalle. Qui l’ideale di un’epica orientata in senso provvidenzialistico e una costante tensione allegorico-polemica intervengono a privilegiare la riflessione rispetto all’istinto e a relegare quest’ultimo ai luoghi deputati della comicità e del ridicolo. L’eterodossia bizzarra di P. sembra ormai in sintonia col razionalismo umanistico del circolo ficiniano, di cui infatti il diavolo Astarotte (altra felice creazione del poema) divulga estrosamente gli ideali di tolleranza religiosa. Se la confessione esplicita di un’ascendenza culturale volutamente «ridotta» (le sue, afferma P., sono «muse domestiche») ascrive Il Morgante a una stagione in declino rispetto ai nuovi orientamenti dell’umanesimo laurenziano, pure a P. resta il merito di aver saputo rivivere l’esperienza burchiellesca, ampliandola oltre i limiti delle rimerie burlesche nella struttura di un poema eroicomico destinato a riprese e innovazioni, dal Baldus di Folengo in poi; e, fuori dalla tradizione italiana e cavalleresca, Il Morgante lasciò il segno sul Gargantua e Pantagruel di Rabelais.